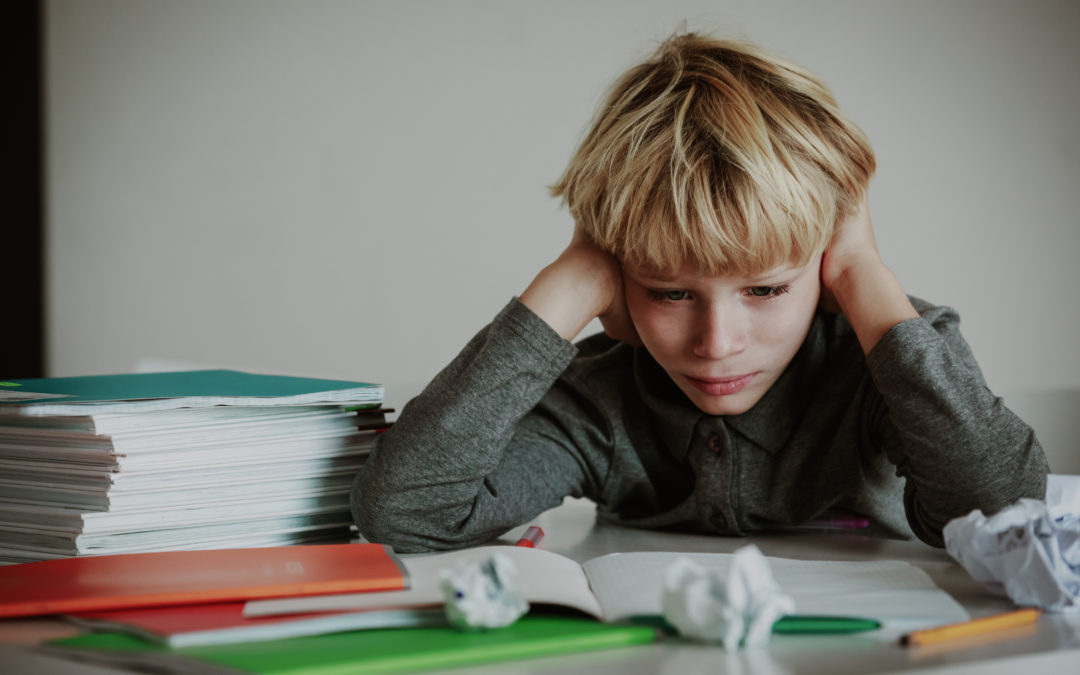Di fronte ad un disturbo è diffusa la tendenza a concentrarsi esclusivamente sulle cause e sulle possibili soluzioni, per affrontarlo e risolverlo il prima possibile. Ciò che spesso sfugge è che il disturbo o la difficoltà rappresentano una parte, certo importante, ma solo una parte della persona. Quest’ultima, infatti, è costituita da tantissime sfaccettature, ognuna importante e fondamentale. Tali aspetti devono essere considerati per poter supportare al meglio il singolo individuo a cui ci rivolgiamo e per consentirgli di affrontare al meglio il suo percorso, sia esso riabilitativo, educativo, scolastico, familiare o personale.
Nei bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), oltre a concentrarci sulle loro fragilità per capire come compensarle, è importante chiedersi come vivono le loro fatiche, cosa provano, quali sono le loro emozioni, per approfondire quale impatto il disturbo specifico dell’apprendimento ha sulla loro vita. La letteratura scientifica riporta che i DSA sono frequentemente associati a disturbi emotivi che, se non vengono elaborati, rappresentano un fattore di rischio per un futuro disagio psicologico (Mugnaini e collaboratori 2008). Come spiegare la relazione tra emozioni e DSA?
Secondo L’OMS la qualità della vita corrisponde alla percezione che la persona ha del proprio benessere e della propria soddisfazione personale nel contesto della cultura e del sistema di valori in cui vive, in relazione ai suoi obiettivi, aspettative, standard e preoccupazioni. I Disturbi specifici dell’apprendimento possono interferire negativamente sulla qualità della vita, perché:
- generano stress e senso di fallimento, inadeguatezza;
- richiedono una riorganizzazione del proprio senso di identità e delle proprie abilità e competenze;
- necessitano di un percorso di accettazione della diagnosi e motivazione all’intervento.
L’attività didattica per un bambino o ragazzo con DSA può risultare eccessiva in termini di richiesta cognitiva, risorse attentive, velocità di elaborazione e capacità di manipolare le informazioni ricevute, pertanto è importante riuscire a cogliere eventuali segnali di disagio, per evitare che si amplifichino con il tempo: lamentele somatiche, umore irritabile o deflesso, manifestazioni ansiose, aggressività, atteggiamenti evitanti, isolamento non devono essere sottovalutati!
Studi recenti evidenziano la stretta relazione esistente tra processi cognitivi e sistemi motivazionali e come questi agiscono sull’apprendimento. La percezione di essere riusciti a superare un compito genera il desiderio di continuare, di proseguire nell’impegno; diversamente, la continua frustrazione determinata dalla non riuscita produce come risposta la rinuncia ad accettare la sfida che quell’attività propone. L’espressione di Atkinson (2007) esprime ancora meglio il concetto sopra riportato: “la persona è disposta a impegnarsi quando la speranza di successo supera la paura dell’insuccesso, altrimenti prevale il senso di vergogna e inattività”. L’alunno che vive continuamente un senso di frustrazione nello studio presenta facilmente scarsa autostima e un basso senso di autoefficacia scolastica. Questo significa che non attribuirà valore a se stesso come studente e, riconoscendosi come incapace, si convince che anche gli insegnanti, i familiari e i compagni possano avere la stessa considerazione di lui.
Il bambino o ragazzo con DSA si trova a far parte di un contesto nel quale spesso vengono proposte attività per lui troppo difficili e astratte, deve confrontarsi con i compagni e frequentemente non si sente membro del gruppo. Inoltre, i bambini e gli adolescenti con difficoltà scolastiche raccontano che devono affrontare continue sollecitazioni e rimproveri dell’adulto: “non hai voglia”, “impegnati di più”, “possibile che non capisci?” e che spesso non trovano soddisfazione neanche nelle attività extrascolastiche. Ecco che quello che si osserva nella pratica clinica è il crescere in questi ragazzi di un forte senso di colpa, ritengono che nessuno sia soddisfatto di loro e possono mettere in atto dei meccanismi di difesa poco funzionali e disadattivi (disimpegno, aggressività, inibizione, chiusura).
Ma quali sono gli esiti emotivi negativi più frequenti correlati ai DSA?
Molto spesso i bambini e i ragazzi provano rabbia ed esprimono aggressività e ciò nasce dalla constatazione che si è, in qualche modo, “diversi dagli altri”, da quelli cioè che riescono a ottenere i risultati a livello scolastico e che per loro sembrano irraggiungibili; questa rabbia è anche l’esito della sofferenza per non essere compresi.
L’aggressività può manifestarsi attraverso schemi comportamentali quali dissentire, offendere e minacciare, compiere atti distruttivi diretti intenzionalmente a danneggiare cose o persone.
Un altro esito emotivo rilevante è la vergogna e la perdita di autostima. A volte l’umiliazione che nasce dal sentirsi perdenti nel rapporto con gli altri si traduce in senso di inferiorità.
La certezza della sconfitta, spesso, porta il bambino o il ragazzo a isolarsi e a evitare situazioni di confronto con i compagni.
Infine, altre problematiche emotive correlate ai DSA sono la paura, l’ansia e la depressione.
La paura è una risposta adattiva legata alla percezione di una minaccia. Nel caso di un soggetto con una difficoltà di apprendimento tale minaccia può essere rappresentata dal giudizio di un adulto di riferimento (insegnanti e genitori) o dei compagni di classe.
L’espressione patologica della paura è costituita dal disturbo ansioso, che si può manifestare tramite somatizzazioni (mal di pancia, cefalea, …), disturbi del sonno, attraverso attacchi di panico e fobie ma anche nell’evitamento emotivo. A lungo andare queste esperienze negative possono portare il ragazzo a un atteggiamento apatico, all’isolamento, al rifiuto di andare a scuola; nei casi più complessi si osserva gradualmente la comparsa di una sintomatologia di carattere depressivo.
Come possiamo allora sostenere al meglio uno studente con DSA? Sicuramente è fondamentale considerare la sfera emotivo/relazionale; certamente bisogna agire sulle difficoltà di lettura, scrittura o matematica, ma senza tralasciare l’importanza della vulnerabilità psicologica che questi disturbi possono portare con sé.
Il Centro Compiti Point, specializzato e accreditato per la certificazione diagnostica dei DSA, attribuisce molta importanza alla spiegazione della diagnosi, ai genitori e al bambino/ragazzo a cui si riferisce, non è solo mera e semplice attribuzione di un’etichetta; lavora inoltre in concerto con la scuola e la famiglia proprio per garantire una presa in carico completa, che possa sostenere al meglio lo studente che ci viene affidato.
Gli aspetti emotivi nei DSA Di fronte ad un disturbo è diffusa la tendenza a concentrarsi esclusivamente sulle cause e sulle possibili soluzioni, per affrontarlo e risolverlo il prima possibile. Ciò che spesso sfugge è che il disturbo o la difficoltà rappresentano una parte, certo importante, ma solo una parte della persona. Quest’ultima, infatti, è costituita da tantissime sfaccettature, ognuna importante e fondamentale. Tali aspetti devono essere considerati per poter supportare al meglio il singolo individuo a cui ci rivolgiamo e per consentirgli di affrontare al meglio il suo percorso, sia esso riabilitativo, educativo, scolastico, familiare o personale. Nei bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), oltre a concentrarci sulle loro fragilità per capire come compensarle, è importante chiedersi come vivono le loro fatiche, cosa provano, quali sono le loro emozioni, per approfondire quale impatto il disturbo specifico dell’apprendimento ha sulla loro vita. La letteratura scientifica riporta che i DSA sono frequentemente associati a disturbi emotivi che, se non vengono elaborati, rappresentano un fattore di rischio per un futuro disagio psicologico (Mugnaini e collaboratori 2008). Come spiegare la relazione tra emozioni e DSA? Secondo L’OMS la qualità della vita corrisponde alla percezione che la persona ha del proprio benessere e della propria soddisfazione personale nel contesto della cultura e del sistema di valori in cui vive, in relazione ai suoi obiettivi, aspettative, standard e preoccupazioni. I Disturbi specifici dell’apprendimento possono interferire negativamente sulla qualità della vita, perché: – generano stress e senso di fallimento, inadeguatezza; – richiedono una riorganizzazione del proprio senso di identità e delle proprie abilità e competenze; – necessitano di un percorso di accettazione della diagnosi e motivazione all’intervento. L’attività didattica per un bambino o ragazzo con DSA può risultare eccessiva in termini di richiesta cognitiva, risorse attentive, velocità di elaborazione e capacità di manipolare le informazioni ricevute, pertanto è importante riuscire a cogliere eventuali segnali di disagio, per evitare che si amplifichino con il tempo: lamentele somatiche, umore irritabile o deflesso, manifestazioni ansiose, aggressività, atteggiamenti evitanti, isolamento non devono essere sottovalutati! Studi recenti evidenziano la stretta relazione esistente tra processi cognitivi e sistemi motivazionali e come questi agiscono sull’apprendimento. La percezione di essere riusciti a superare un compito genera il desiderio di continuare, di proseguire nell’impegno; diversamente, la continua frustrazione determinata dalla non riuscita produce come risposta la rinuncia ad accettare la sfida che quell’attività propone. L’espressione di Atkinson (2007) esprime ancora meglio il concetto sopra riportato: “la persona è disposta a impegnarsi quando la speranza di successo supera la paura dell’insuccesso, altrimenti prevale il senso di vergogna e inattività”. L’alunno che vive continuamente un senso di frustrazione nello studio presenta facilmente scarsa autostima e un basso senso di autoefficacia scolastica. Questo significa che non attribuirà valore a se stesso come studente e, riconoscendosi come incapace, si convince che anche gli insegnanti, i familiari e i compagni possano avere la stessa considerazione di lui. Il bambino o ragazzo con DSA si trova a far parte di un contesto nel quale spesso vengono proposte attività per lui troppo difficili e astratte, deve confrontarsi con i compagni e frequentemente non si sente membro del gruppo. Inoltre, i bambini e gli adolescenti con difficoltà scolastiche raccontano che devono affrontare continue sollecitazioni e rimproveri dell’adulto: “non hai voglia”, “impegnati di più”, “possibile che non capisci?” e che spesso non trovano soddisfazione neanche nelle attività extrascolastiche.
Ecco che quello che si osserva nella pratica clinica è il crescere in questi ragazzi di un forte senso di colpa, ritengono che nessuno sia soddisfatto di loro e possono mettere in atto dei meccanismi di difesa poco funzionali e disadattivi (disimpegno, aggressività, inibizione, chiusura). Ma quali sono gli esiti emotivi negativi più frequenti correlati ai DSA? Molto spesso i bambini e i ragazzi provano rabbia ed esprimono aggressività e ciò nasce dalla constatazione che si è, in qualche modo, “diversi dagli altri”, da quelli cioè che riescono a ottenere i risultati a livello scolastico e che per loro sembrano irraggiungibili; questa rabbia è anche l’esito della sofferenza per non essere compresi. L’aggressività può manifestarsi attraverso schemi comportamentali quali dissentire, offendere e minacciare, compiere atti distruttivi diretti intenzionalmente a danneggiare cose o persone. Un altro esito emotivo rilevante è la vergogna e la perdita di autostima. A volte l’umiliazione che nasce dal sentirsi perdenti nel rapporto con gli altri si traduce in senso di inferiorità. La certezza della sconfitta, spesso, porta il bambino o il ragazzo a isolarsi e a evitare situazioni di confronto con i compagni. Infine, altre problematiche emotive correlate ai DSA sono la paura, l’ansia e la depressione. La paura è una risposta adattiva legata alla percezione di una minaccia. Nel caso di un soggetto con una difficoltà di apprendimento tale minaccia può essere rappresentata dal giudizio di un adulto di riferimento (insegnanti e genitori) o dei compagni di classe. L’espressione patologica della paura è costituita dal disturbo ansioso, che si può manifestare tramite somatizzazioni (mal di pancia, cefalea, …), disturbi del sonno, attraverso attacchi di panico e fobie ma anche nell’evitamento emotivo. A lungo andare queste esperienze negative possono portare il ragazzo a un atteggiamento apatico, all’isolamento, al rifiuto di andare a scuola; nei casi più complessi si osserva gradualmente la comparsa di una sintomatologia di carattere depressivo. Come possiamo allora sostenere al meglio uno studente con DSA? Sicuramente è fondamentale considerare la sfera emotivo/relazionale; certamente bisogna agire sulle difficoltà di lettura, scrittura o matematica, ma senza tralasciare l’importanza della vulnerabilità psicologica che questi disturbi possono portare con sé. Il Centro Compiti Point, specializzato e accreditato per la certificazione diagnostica dei DSA, attribuisce molta importanza alla spiegazione della diagnosi, ai genitori e al bambino/ragazzo a cui si riferisce, non è solo mera e semplice attribuzione di un’etichetta; lavora inoltre in concerto con la scuola e la famiglia proprio per garantire una presa in carico completa, che possa sostenere al meglio lo studente che ci viene affidato.